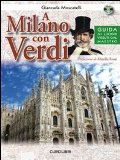Ieri sera all'Auditorium di Milano si è tenuto il secondo concerto della serie dedicata a Dvorak e diretta da Aldo Ceccato che in tre anni vedrà l'esecuzione di tutte le sinfonie, dei concerti e dei poemi sinfonici.
La fama di Dvorak è strana perchè se si dice Dvorak molti dicono "Che bello!" ma poi, se si va a guardare, se si esula dalla IX sinfonia "Dal nuovo mondo", di cui comperai il disco diretto da Toscanini nel 1967 e alla cui esecuzione alla fin fine sono sempre rimasto fedele, dal concerto per violoncello e dalle danze slave, la prima serie perché con la seconda già andiamo malino, di Dvorak si conosce abbastanza poco. I concerti per violino e per pianoforte sono praticamente sconosciuti, i poemi sinfonici raramente eseguiti, il bellissimo Requiem o l'ancor più bello Stabat Mater ancora meno, come pure i quartetti, a parte il quartetto "Americano", i trii, i quintetti, le opere pianistiche e le opere liriche.
Il concerto si è aperto con lo Scherzo capriccioso op. 66 del 1883, un brano che dura meno di un quarto d'ora, dalla brillante orchestrazione e originale nella struttura con passaggi lirici e accensioni immediate, insomma, Dvorak al 100%; una composizione che mi è sempre piaciuta molto. Tra l'altro, proprio per questo aspetto così brillante e vario, con passaggi ora misteriosi quasi onirici con l'arpa, ora sgargianti che portano ad una coda travolgente, anni fa leggevo che questo brano sarebbe particolarmente indicato in musicoterapia per i depressi ed in effetti se si è un po' di cattivo umore e un po' giù, soprattutto qua a Milano e manca il mare da guardare, una musica come questa può far stare meglio. Purtroppo l'esecuzione di Ceccato non è stata propriamente vivace. Non è stata una cattiva esecuzione ma mi è parso che il brano fosse preso un po' troppo con circospezione già a partire dalla prima entrata dei corni; invece questa è una musica da prendere proprio di petto, animandola di vita fino alla stretta finale che deve essere sempre più incalzante e correre spedita: sentire per referenze Kubelik o Kertesz, ma anche Sawallisch che da buon tedesco trova vene brahmsiane in questa musica ma comunque corre senza indugi fino alla conclusione che si porta via tutto. Il pubblico ha reagito all'esecuzione del brano con una certa flemma: un applausino senza ulteriori richiami.
Poi è arrivato il concerto per pianoforte Op. 33 del 1876. Come ricorda Piero Rattalino nel suo libro sulla storia del concerto per pianoforte e orchestra, questo concerto voleva andare a risolvere un problema, ovvero come tentare una sintesi tra il virtuosismo esasperato e il rapporto con l'orchestra in modo che quest'ultima non fosse relegata al ruolo di comprimario, ovvero Dvorak cercò di scrive un concerto per pianoforte e orchestra e non un concerto per pianoforte con accompagnamento orchestrale. Quindi questo concerto ha un considerevole spessore sinfonico e la parte pianistica è molto difficile, ma con difficoltà sproporzionate all'effetto virtuostico che in realtà producono. Di conseguenza il concerto non fece molta presa sul pubblico e neanche sui pianisti. Quarant'anni dopo il pianista Vilém Kurz revisionò la parte pianistica semplificandola un po' ma non raggiunse l'effetto sperato di rilanciare la fama del concerto. In effetti si dovette attendere che di questo concerto se ne occupasse Sviatoslav Richter,che assieme all'inarrivabile e sommo Carlos Kleiber ne fece una registrazione discografica, per dimostrare il valore di questo concerto e la sua importanza storica. Con tutto ciò questo è ancora un concerto eseguito poco e quindi in genere poco conosciuto; personalmente in quasi 44 anni di frequentazione di sale da concerto un po' ovunque questa è stata la prima occasione in cui l'ho potuto ascoltare dal vivo. Qui le cose sono andate meglio. I tempi erano giusti e il pianista Benedetto Lupo, vecchia conoscenza in Auditorium, è stato come al solito molto bravo ed efficace pur nel compito non sempre grato di suonare questo concerto (che figurone si fà invece con Chopin o Ciaikovskij!).
Il concerto si è concluso con l'VIII sinfonia in sol maggiore op. 88 del 1890. Questa è una sinfonia che amo molto, se possibile più della famosa IX perchè l'ho sempre trovata ottimamente scritta e originale nella forma fantasiosa. Tra l'altro questa sinfonia contiene un movimento lento veramente incantevole con quei clarinetti così nostalgici e un terzo tempo, una specie di minuetto, che, per me, è il più bel terzo tempo di sinfonia che Dvorak abbia mai scritto, meraviglioso nel primo tema e con un trio che amplifica ulteriormente questa meraviglia. Il finale è un tema con variazioni che si apre con una fanfara delle trombe e si conclude con colori incandescenti e travolgenti. Non dico nulla del primo movimento perchè appena dopo l'inizio un signore tre file davanti alla mia si è sentito male e ci è voluto quasi tutto il movimento per portarlo via, grazie all'intervento di robusti pompieri; il tutto è stato fatto con grande discrezione. Alla fine del concerto era nell'atrio in attesa di tornare a casa con la comitiva di cui faceva parte e stava molto meglio, a quanto mi ha detto una persona dello staff.
L'esecuzione è stata buona, direi, anche molto buona nelle parti più meditative; nel finale, però, un po' di verve in più non sarebbe guastata. Insomma con Dvorak, compositore esaltante come pochi, bisogna anche darci dentro un po' quando serve. E' un peccato perchè l'orchestra Verdi è capace di grandi dinamismi (me la ricordo bene in certe esecuzioni di Stravinskij, di Shostakovich ed altri) e mi è sembrato che fosse come un po' trattenuta.
Pubblico non foltissimo, applausi in genere pochini (quelli maggiori sono venuti alla fine con concerto per pianoforte in attesa del bis).
Peccato perchè l'orchestra meriterebbe in ogni caso maggiori riconoscimenti dal proprio pubblico per l'impegno.